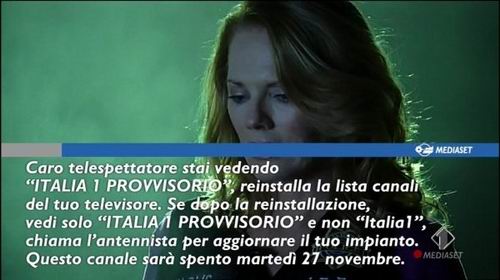Juve Stabia – Hellas Verona
( Attacca ‘o ciuccio addò rice ‘o patrone )
A scadenza fissa ritornano le cronache dei contrasti ideologici di natura razzistica delle varie tifoserie calcistiche delle squadre del nord e di quelle del sud.
Le cronache ritornano quando negli stadi si ripetono incidenti, si notano striscioni stupidi e si ascoltano cori imbecilli. Ma la verità è che quella mentalità deteriore cova e si alimenta nelle menti dei soggetti che, poi, la manifestano attraverso le iniziative indicate, come sfogo di un malessere personale. E sempre a loro completo disonore. Quelle manifestazioni, infatti, sono il segno evidente del ritardo culturale e civile in cui versano – e questo, bello non è – gli attori delle azioni sopra ricordate, di cui si alimenta la cronaca giornalistica
Si riteneva che il gioco del calcio, in mancanza di altre agenzie educative o in sintonia con esse, potesse aiutare a crescere i supporters di tutte le squadre, aggregando simpatie e passioni campanilistiche e favorendo così la socializzazione, e, con essa, la conoscenza di altre persone, di altre città e, nello stesso tempo, lo scambio di esperienze e di gesti di solidarietà. Tutto questo all’interno di un sistema (il gioco del calcio) che come sport avrebbe dovuto esaltare la lealtà; e come sistema di regole – in campo (le regole dl calcio) e fuori dal campo (nella gestione dei gruppi sportivi e delle associazioni ad essi collegati) – avrebbe dovuto esaltare la legalità. A questo servono le associazioni, i club, i gruppi: ad evidenziare l’identità culturale degli associati, ma solo per fargli superare blocchi psicologici e ritardi di civiltà; non certo a confondere l’individualità di ognuno e ad annullarne il senso di responsabilità.
E invece, …. .
* * *
Prendendo spunto dalle recenti controversie (offese – polemiche – ricorsi – contro-ricorsi – ecc.) intrattenute tra Hellas Verona e Juve Stabia, voglio ricordare alcuni episodi risalenti alla mia esperienza personale avuta con amici e colleghi veronesi. Non dirò di quegli stupidi comportamenti – miserie umane! – che non mancano mai da parte di persone che non riescono a confrontarsi tenendo fermo l’inderogabile assunto che l’altro, comunque, vada rispettato. Di fronte a questi casi ho sempre evitato di fare polemica, perché “a lavar la testa all’asino, …. ecc., ecc., …”
Ho sempre cercato di offrire all’ottuso di turno esempi di dignità e di tolleranza.
Se ci sia riuscito non so.
Perciò preferisco piuttosto raccontare di quelle situazioni che hanno fatto chiarezza di pregiudizi e di comportamenti conseguenti, non proprio sereni nella valutazione dell’altro. Nell’una e nell’altra direzione, perché. nonostante quei pregiudizi si era pur sempre amici o colleghi, e si continuava comunque a rimanere tali. Se pure con qualche forma di circospezione.
* * *
A Verona io ci ho lavorato. E ho avuto modo di apprezzare la precisione e il senso del dovere dei colleghi veneti. Insieme anche a qualche difettuccio.
Nella stazione di Verona Porta Nuova delle Ferrovie dello Stato, un giorno ero in servizio alla Biglietteria dietro uno dei tanti sportelli aperti nelle ore di punta quando numerosi viaggiatori – studenti, lavoratori pendolari, turisti, viaggiatori occasionali – si affollavano in lunghe file nell’atrio. Un collega alla destra, un altro alla sinistra, e così di seguito, a ranghi compatti per tutta la linea degli sportelli come in una trincea, si cercava si smaltire la massa dei viaggiatori. A sinistra avevo Menini, a destra il Titta – così chiamavamo Augusto Piubello – , e tutti e tre, come gli alti fino all’ultimo sportello, eravamo alle prese con la macchina automatica in dotazione all’epoca: la SASIB, la quale, dopo averlo ingoiato il cartoncino rettangolare bianco, lo stampigliava per risputarlo come un biglietto ferroviario: data, destinazione, importo, validità e numero di serie. L’operatore doveva solo selezionare su richiesta del viaggiatore la città di arrivo; e lo faceva sopra un grande pannello su cui scorreva la striscia di plexiglass con un movimento orizzontale/verticale, come se seguisse un’immaginaria coppia di assi cartesiani. Per accelerare le operazioni di pagamento, ognuno poi aveva escogitato la sua tecnica personale nel calcolare il resto da dare insieme al biglietto. Visto che la maggior parte della clientela pagava con valuta cartacea di taglio elevato.
A tutti noi sarà capitato di avere avuto qualche discussione agli sportelli pubblici su chi dovesse procurarsi la moneta spicciola, se il cliente oppure l’impiegato di servizio allo sportello.
Ebbene quel giorno in seguito alla difficoltà in cui si trovava il Titta nel dare il resto al viaggiatore, si animò una controversia rispettosa e bonaria con un viaggiatore per vedere a chi dei due toccasse andare a procurarsi la moneta contante. Nonostante le maniere garbate della discussione nessuno si decideva a cedere, adducendo sempre nuove argomentazioni a sostegno della propria tesi. Alla fine perdendo la pazienza il viaggiatore che fin allora aveva parlato sempre in italiano senza la minima inflessione dialettale sbottò, dicendo, nel più schietto napoletano: “Aggio capito: attacca ‘o ciuccio addò rice ‘o patrone”. Il Titta restò perplesso, e senza comprendere neanche una parola credette che il simpatico viaggiatore volesse offenderlo.
Quella espressione napoletana era di mia conoscenza, come pure mi era familiare la parlata; ma ciò che particolarmente richiamò la mia attenzione fu il fatto che avesse sanzionato con quella sentenza un battibecco che non avevo potuto seguire durante tutta la contrastata operazione di acquisto del biglietto. Mi stupiva inoltre l’esitazione del Titta che a quelle parole incomprensibili per lui e credute un improperio, non sapesse trovare una risposta, né sapeva perciò come reagire. Allora per toglierlo dall’impaccio mi sporsi verso il suo sportello fino a farmi vedere dal viaggiatore, al quale prontamente e perentoriamente risposi: “Sono del tutto d’accordo; ma anche lei dovrà convenire con me che è sempre meglio attaccà ‘o ciuccio addò rice ‘o patrone, anziché attaccà ‘o patrone addò rice ‘o ciuccio. O no?”
E la cosa si sciolse con una risata generale. Allora il signore, a sua volta sorpreso, andò a procurarsi la moneta spicciola.
* * *
La cosa strana si verificò dopo, quando rimasto solo col Titta egli mi chiese che cosa avesse detto quel signore e che cosa gli avessi risposto io. Allora, sentita la traduzione che gli feci delle espressioni napoletane, lui mostrò meraviglia che io, napoletano, mi fossi schierato contro un napoletano prendendo le difese di un veronese. Però ancora più grande fu il mio stupore di fronte alla sua meraviglia.
E ce ne volle per fargli capire che, data la situazione e valutate le ragioni dell’uno o dell’altro, non avevo esitato a mettermi dalla parte di chi a me, a torto o a ragione, sembrava essere nel giusto. Veronese o napoletano che fosse.
Luigi Casale